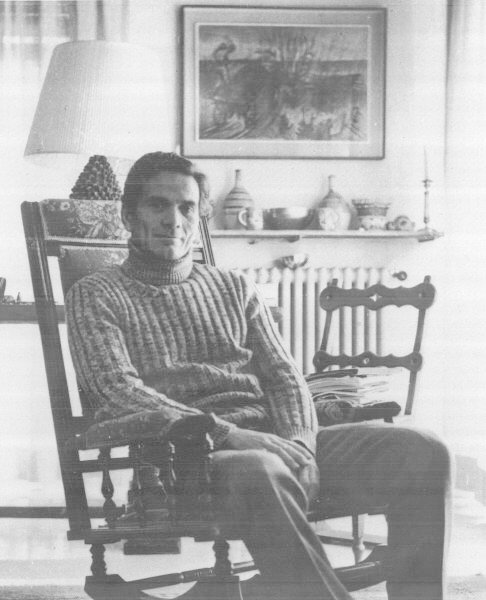|
 |
| Amado mio / Atti impuri | Su Pier Paolo Pasolini... | |
|
|
||
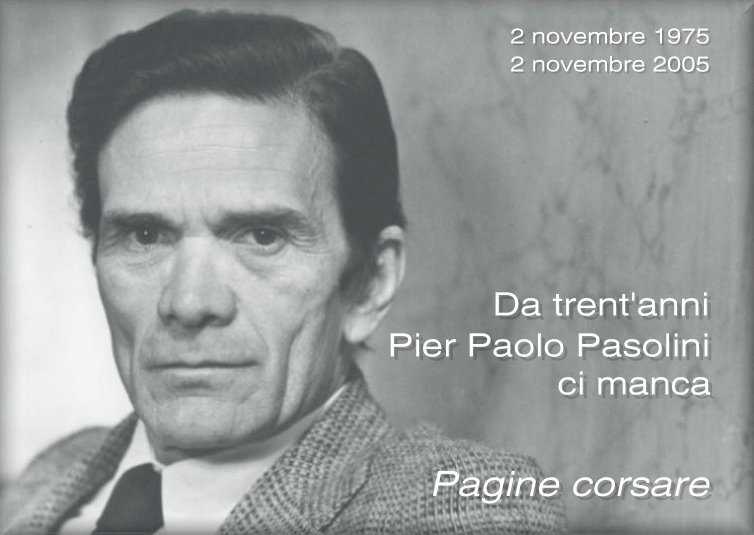 |
|
|
Il sogno di una cosa fu il primo esperimento narrativo di Pasolini, composto nel '49-'50, a seguito degli avvenimenti italiani del '48-'49, quando il 'Lodo De Gasperi', che stabiliva rapporti di lavoro più equi tra proprietari terrieri e contadini, spinse questi ultimi a rivendicarne l'osservanza da parte dei recalcitranti padroni friulani. La storia è quasi completamente ambientata nelle campagne friulane, tra i contadini che si incontrano alle sagre di paese, vivono rapporti semplici e genuini, e cercano di migliorare la propria vita emigrando, cercando lavoro nelle miniere o reclamandolo con azioni politiche, sempre intenzionalmente pacifiche. Il mondo contadino ritratto da Pasolini appare come il vero depositario dei valori positivi: l'amicizia, l'amore, la solidarietà, la famiglia. Protagonisti principali sono tre ragazzi di paese che diventano amici durante la prima sagra, episodio d'apertura del romanzo. Un esempio della genuinità di sensazioni e sentimenti lo possiamo cogliere immediatamente, nella fase iniziale di questa amicizia: «Ormai l'amicizia era fatta: era tanto che i due giovani desideravano conoscersi, che si guardavano: una volta c'era stata anche quasi una lite tra di loro per colpa di una involontaria spinta che si erano dati ballando: ed era da allora che si erano fatti amici. Adesso, dopo le prime parole, cominciava a entrare nei loro discorsi un entusiasmo, un calore che rendeva bella qualsiasi cosa: l'idea di andare a bere un bicchiere, la più comune che si potesse avere in quel momento, gli parve stupenda; e specie dopo che ebbero bevuto non uno, ma due o tre bicchieri di vino, pendevano uno dalle labbra dell'altro come se certe cose, l'organizzazione di una sagra, la bravura di un'orchestrina da ballo e le ragazze di Gruaro,
 fossero argomenti trattati per la prima volta dalla creazione del mondo». (pag. 22)Non c'è mai finzione o sotterfugio: ciò che questi personaggi dicono è esattamente ciò che pensano; tutto è trasparenza, non c'è mediazione, forse perché non possiedono quella malizia tipica delle menti abituate a pensare troppo. La vita, dalle loro parti, è veramente ridotta all'essenza: basta una bottiglia di vino, un'armonica e un po' di gente per dare una svolta a una serata, a un pomeriggio; basta vedere l'ingiusta ricchezza dei proprietari terrieri per far loro decidere che è giunto il momento di agire, non per un'ideale comunista del quale sono culturalmente coscienti, ma per un comunismo che hanno dentro se stessi, una coscienza di classe che va al di là degli altisonanti discorsi politici. Non è un romanzo dalle grandi parole o dalle grandi strategie politiche, non c'è un leader a dirigere le azioni, ma semplicemente il popolo che cerca giustizia, e che lo fa nel suo tipico modo genuino, a volte intimidito da chi ha il potere, a volte incoraggiato dalla vicinanza degli altri. Pasolini amava ritrarre la gente delle classi più semplici (per semplici intendo meno mascherate, più facili da avvicinare). Questo suo amore lo ha dimostrato anche con Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta, attraverso la gente di paese e di borgata i suoi romanzi riescono a trasmettere l'immediatezza della vita quotidiana e a farci sentire una certa nostalgia per un tipo di rapporti umani più genuino. Una particolarità che ho notato e che mi ha fatto pensare a quanto questi rapporti fossero fondamentali in Pasolini, è la presenza, ne Il Sogno di una Cosa, del vino: colore e calore vivo, sempre pronto a fungere da collante per un paio d'ore da trascorrere insieme. L'effetto 'loquacizzante' del vino è conosciuto a tutti, ma in questo testo ha un ruolo primario: quando i protagonisti vengono ritratti nella loro vita quotidiana o in particolari momenti festosi, li troviamo sempre attorno a un tavolo o davanti a un camino a bere tutti insieme; quando la situazione si fa difficile, non bevono più, il vino sparisce e con esso calore e colore. Il bere e il mangiare sono due degli aspetti al centro della vita di tutti gli uomini, ma in genere nei romanzi sono momenti della giornata che vengono trascurati per privilegiare quella che è la trama principale. Una delle differenze tra homo sapiens (l'uomo reale, in carne ed ossa) e homo fictus (l'uomo fabbricato, inventato, il personaggio) sta nel fatto che l'uomo reale mangia, beve e dorme, mentre il personaggio dei romanzi non viene quasi mai descritto mentre svolge queste azioni, considerate tempi morti ai fini di una trama. Se ci rendiamo conto di quanto invece in Pasolini ci sia attenzione per questi sacrosanti momenti della giornata di un uomo, sia esso sapiens che fictus, arriviamo facilmente alla conclusione che i suoi personaggi non vivono d'aria, ma di pane, carne e vino come noi stessi, e per questo ci capita di sorridere più spesso quando leggiamo storie come questa, in cui riconosciamo i nostri momenti più 'rustici', in cui non dobbiamo riflettere sul senso delle parole di un dato personaggio che dovrebbe trasmetterci chissà quale messaggio filosofico, ma semplicemente lasciarci trasportare dalle parole dei protagonisti e entrare nel loro mondo. fossero argomenti trattati per la prima volta dalla creazione del mondo». (pag. 22)Non c'è mai finzione o sotterfugio: ciò che questi personaggi dicono è esattamente ciò che pensano; tutto è trasparenza, non c'è mediazione, forse perché non possiedono quella malizia tipica delle menti abituate a pensare troppo. La vita, dalle loro parti, è veramente ridotta all'essenza: basta una bottiglia di vino, un'armonica e un po' di gente per dare una svolta a una serata, a un pomeriggio; basta vedere l'ingiusta ricchezza dei proprietari terrieri per far loro decidere che è giunto il momento di agire, non per un'ideale comunista del quale sono culturalmente coscienti, ma per un comunismo che hanno dentro se stessi, una coscienza di classe che va al di là degli altisonanti discorsi politici. Non è un romanzo dalle grandi parole o dalle grandi strategie politiche, non c'è un leader a dirigere le azioni, ma semplicemente il popolo che cerca giustizia, e che lo fa nel suo tipico modo genuino, a volte intimidito da chi ha il potere, a volte incoraggiato dalla vicinanza degli altri. Pasolini amava ritrarre la gente delle classi più semplici (per semplici intendo meno mascherate, più facili da avvicinare). Questo suo amore lo ha dimostrato anche con Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta, attraverso la gente di paese e di borgata i suoi romanzi riescono a trasmettere l'immediatezza della vita quotidiana e a farci sentire una certa nostalgia per un tipo di rapporti umani più genuino. Una particolarità che ho notato e che mi ha fatto pensare a quanto questi rapporti fossero fondamentali in Pasolini, è la presenza, ne Il Sogno di una Cosa, del vino: colore e calore vivo, sempre pronto a fungere da collante per un paio d'ore da trascorrere insieme. L'effetto 'loquacizzante' del vino è conosciuto a tutti, ma in questo testo ha un ruolo primario: quando i protagonisti vengono ritratti nella loro vita quotidiana o in particolari momenti festosi, li troviamo sempre attorno a un tavolo o davanti a un camino a bere tutti insieme; quando la situazione si fa difficile, non bevono più, il vino sparisce e con esso calore e colore. Il bere e il mangiare sono due degli aspetti al centro della vita di tutti gli uomini, ma in genere nei romanzi sono momenti della giornata che vengono trascurati per privilegiare quella che è la trama principale. Una delle differenze tra homo sapiens (l'uomo reale, in carne ed ossa) e homo fictus (l'uomo fabbricato, inventato, il personaggio) sta nel fatto che l'uomo reale mangia, beve e dorme, mentre il personaggio dei romanzi non viene quasi mai descritto mentre svolge queste azioni, considerate tempi morti ai fini di una trama. Se ci rendiamo conto di quanto invece in Pasolini ci sia attenzione per questi sacrosanti momenti della giornata di un uomo, sia esso sapiens che fictus, arriviamo facilmente alla conclusione che i suoi personaggi non vivono d'aria, ma di pane, carne e vino come noi stessi, e per questo ci capita di sorridere più spesso quando leggiamo storie come questa, in cui riconosciamo i nostri momenti più 'rustici', in cui non dobbiamo riflettere sul senso delle parole di un dato personaggio che dovrebbe trasmetterci chissà quale messaggio filosofico, ma semplicemente lasciarci trasportare dalle parole dei protagonisti e entrare nel loro mondo. |
|
Teoria dei due paradisi C’era un’alleanza dei sensi
Il grembo ch’era come un sole coperto da nuvole |